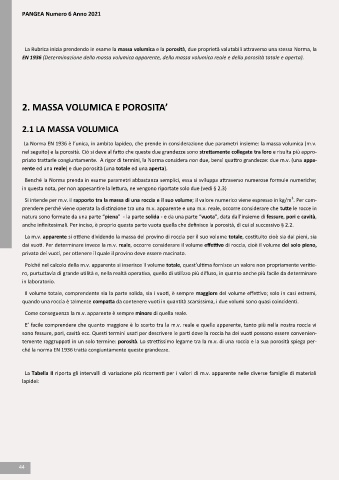Page 44 - C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\msoF529.tmp
P. 44
PANGEA Numero 6 Anno 2021
La Rubrica inizia prendendo in esame la massa volumica e la porosità, due proprietà valutabili attraverso una stessa Norma, la
EN 1936 (Determinazione della massa volumica apparente, della massa volumica reale e della porosità totale e aperta).
2. MASSA VOLUMICA E POROSITA’
2.1 LA MASSA VOLUMICA
La Norma EN 1936 è l’unica, in ambito lapideo, che prende in considerazione due parametri insieme: la massa volumica (m.v.
nel seguito) e la porosità. Ciò si deve al fatto che queste due grandezze sono strettamente collegate tra loro e risulta più appro-
priato trattarle congiuntamente. A rigor di termini, la Norma considera non due, bensì quattro grandezze: due m.v. (una appa-
rente ed una reale) e due porosità (una totale ed una aperta).
Benché la Norma prenda in esame parametri abbastanza semplici, essa si sviluppa attraverso numerose formule numeriche;
in questa nota, per non appesantire la lettura, ne vengono riportate solo due (vedi § 2.3)
3
Si intende per m.v. il rapporto tra la massa di una roccia e il suo volume; il valore numerico viene espresso in kg/m . Per com-
prendere perché viene operata la distinzione tra una m.v. apparente e una m.v. reale, occorre considerare che tutte le rocce in
natura sono formate da una parte “piena” - la parte solida - e da una parte “vuota”, data dall’insieme di fessure, pori e cavità,
anche infinitesimali. Per inciso, è proprio questa parte vuota quella che definisce la porosità, di cui al successivo § 2.2.
La m.v. apparente si ottiene dividendo la massa del provino di roccia per il suo volume totale, costituito cioè sia dai pieni, sia
dai vuoti. Per determinare invece la m.v. reale, occorre considerare il volume effettivo di roccia, cioè il volume del solo pieno,
privato dei vuoti, per ottenere il quale il provino deve essere macinato.
Poiché nel calcolo della m.v. apparente si inserisce il volume totale, quest’ultima fornisce un valore non propriamente veritie-
ro, purtuttavia di grande utilità e, nella realtà operativa, quello di utilizzo più diffuso, in quanto anche più facile da determinare
in laboratorio.
Il volume totale, comprendente sia la parte solida, sia i vuoti, è sempre maggiore del volume effettivo; solo in casi estremi,
quando una roccia è talmente compatta da contenere vuoti in quantità scarsissima, i due volumi sono quasi coincidenti.
Come conseguenza la m.v. apparente è sempre minore di quella reale.
E’ facile comprendere che quanto maggiore è lo scarto tra la m.v. reale e quella apparente, tanto più nella nostra roccia vi
sono fessure, pori, cavità ecc. Questi termini usati per descrivere le parti dove la roccia ha dei vuoti possono essere convenien-
temente raggruppati in un solo termine: porosità. Lo strettissimo legame tra la m.v. di una roccia e la sua porosità spiega per-
ché la norma EN 1936 tratta congiuntamente queste grandezze.
La Tabella II riporta gli intervalli di variazione più ricorrenti per i valori di m.v. apparente nelle diverse famiglie di materiali
lapidei:
44